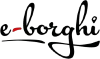Navigando, già da lontano si scorge la Torre Millenaria occhieggiare su questo luogo sospeso, che appare subito un mondo a sè stante. A cominciare dalla sua posizione raccolta, tra l’ultima punta litoranea di Lignano e la Laguna di Grado, e protetta dal mare aperto da una serie di isole e isolette, come quelle di Martignano e di Sant’Andrea, anche nota come l’Isola delle conchiglie.
Fino alla fine dell’Ottocento, qui, tutto era cinto da mura: nemmeno i Turchi, nel Cinquecento, riuscirono a fare breccia. E la Repubblica di Venezia, che governò queste terre dal Quattrocento alla fine del Settecento, cercò in ogni modo di tenersela stretta. La gente è tuttora riconoscente: la Serenissima rispettò l’autonomia locale e i maranesi vanno dicendo ancora oggi, con fierezza, di essere l’unico paese friulano dove si parla il veneto. Ma, oltre ad aver creato trame linguistiche e culturali, Venezia ha lasciato a Marano anche una forte impronta architettonica. Il centro storico è tutto un susseguirsi di calli e piazzette, verso cui le case si spingono, sfociando in spazi comuni di incontro e lavoro all’aperto. Gli edifici sono vestiti con gingilli che raccontano una storia antica: bassorilievi, visi di pietra, stemmi.
Qui, nella laguna, s’apre la Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella, che non è raggiungile via terra. L’acqua è la sola via attraverso cui si arriva al delta del fiume Stella, che si può risalire fino alle località di Precenicco e Palazzolo dello Stella. Lasciando la barca presso una marina è possibile visitare l’area con le apposite motonavi turistiche. Si entra così in un microcosmo eccezionale, vero paradiso per il birdwatching: tra i canneti che costeggiano il letto fluviale, vivono, tra gli altri, falchi di palude, cigni reali, aironi rossi, cinerini e bianchi.
Da uno dei rami più suggestivi del delta, in un percorso effettuato da quasi quarant’anni da una motonave che guida i turisti alla scoperta della laguna, si entra nell’estrema foce. Davanti agli occhi s’apre uno spettacolo di rara bellezza: un villaggio di casoni. Fatti di canna e legno, custodivano al centro un focolare ed erano arredati solo con il necessario per la sopravvivenza. Tutte le capanne guardano a ovest: è il versante più riparato dai venti di bora e tramontana. Un pontile in legno permette oggi l’attracco.
Ogni anno la domenica dopo il 15 giugno, imperdibile è la festa di San Vito con l’antichissima processione in mare.