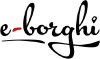Due erano i principali insediamenti protostorici collinari della penisola muggesana, quello di Elleri (età del bronzo medio, 1600 a.C.) e quello posto sul sito, oggi chiamato Muggia Vecchia (età del ferro, VIII-VI secolo a.C.). Dopo l'inizio della penetrazione romana nel Friuli e la fondazione di Aquileia nel 181 a.C., il territorio muggesano venne conquistato insieme al resto dell'Istria con le campagne condotte nel 178-177 a.C. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, il territorio muggesano sottostette alle varie dominazioni dei Longobardi, dei Bizantini e dei Franchi e nel 931 la Terra di Muggia venne donata dai re d'Italia Ugo e Lotario al Patriarcato di Aquileia. Nel 1353 il Castrum sul colle subì una pesante incursione da parte dei dirimpettai triestini, che mise in ginocchio la comunità, già in fase di lento trasferimento nella borgata a mare, in fase di ampliamento. Con la perdita del potere temporale del Patriarca di Aquileia nel 1420, l’ormai consolidata Muggia a valle scelse di sottomettersi alla Repubblica di Venezia con un atto di dedizione. Già nel sec. XIII troviamo menzionato un borgo a mare, chiamato Borgolauro, che venne ampliato nel corso dei secoli e fortificato da robuste mura e torri, per gran parte visibili ancor oggi.
Dopo la fine della Repubblica di Venezia (1797) e concluse le alterne presenze napoleoniche nel 1813, la cittadina passò sotto il dominio asburgico fino al 1918, quindi venne annessa al Regno d’Italia nel 1921, dopo la prima guerra mondiale; terminata la seconda, dopo quaranta giorni di presenza dell’Esercito jugoslavo, subentrò l’amministrazione anglo-americana fino al 25 ottobre 1954 e quindi quella italiana da quella data. In questa occasione venne rettificato il confine e il territorio comunale perse un buona metà del suo territorio sul lato meridionale, con un conseguente e doloroso “esodo interno”.
Nel 1858 s’iniziarono le costruzioni nel Cantiere navale San Rocco, allestito nell’omonima frazione per volontà della famiglia Strudthoff. Ben presto esso divenne un punto di riferimento per la cantieristica navale, che richiamò mano d’opera da Venezia e dai territori vicini. Negli anni settanta del sec. XIX venne costruito il bacino di carenaggio, la più grande struttura privata di questo tipo presente all’epoca nel Mediterraneo orientale. Il cantiere venne declassato alla fine del sec. XIX con conseguenti e pesanti ripercussioni sulla classe operaia cittadina. Un pericoloso esodo in massa verso la vicina Trieste venne arginato, costituendo la Società di Navigazione Muggesana (1897) in seguito municipalizzata, che permise un spostamento giornaliero della mano d’opera nei cantieri della sponda opposta del Vallone. Dopo la seconda guerra mondiale si svilupparono i cantieri Martinuzzi e Felszegy, quest’ultimo ebbe risonanza e fama a livello internazionale, per poi continuare con altri nomi, fino a venir chiuso in seguito alla crisi del settore. Alla fine del sec. XIX c’era ancora qualche anziano, che si esprimeva in muglisano, una parlata ladina da considerare come una variante della lingua friulana. Le testimonianze di questo idioma vennero raccolte dall'abate Jacopo Cavalli e pubblicate sulla rivista triestina Archeografo Triestino nel 1894.
Muggia, posta all’estremo lembo di levante della penisola italica, popolarmente Muia e in sloveno Milje, propone le caratteristiche architetture delle borgate costiere istriane. La cittadina è separata da Trieste da un ampio Vallone, nel cui mezzo passava il confine di stato tra la Casa d’Austria e la Repubblica di Venezia fino al 1797. I secolari rapporti con Venezia si evidenziano nelle prospettive, che si colgono camminando per le calli della cittadina, ricche di stemmi e fregi di rilievo e di particolari unici come i graffiti di calle del Ghetto per poi terminare nella piazza principale con la meravigliosa immagine della facciata del duomo, citato ed esemplare esempio di gotico veneziano. Alla sua destra l’edificio del Municipio, ricostruito secondo le linee architettoniche del momento in seguito all’incendio del 1930. Non va scordata la chiesa dei primi anni del sec. XIV, con attiguo convento, appartenuta all’Ordine francescano; sulle rovine del convento venne costruita la casa parrocchiale alla metà degli anni sessanta (sec. XX).
Il castello venne fatto edificare dal Patriarca di Aquileia, cui la cittadina apparteneva, con inizio nel 1375 (venne terminato nel 1399), per tenere sotto controllo la sempre irrequieta Muggia, in particolare dopo i moti, che videro il muggesano Raffaele di ser Steno, della fazione filo veneta, impadronirsi della cittadina e reggerne le sorti dispoticamente per due anni, dai primi di novembre del 1372 ai primi di novembre del 1374. Acquistato nel 1991, lo scultore muggesano Villibossi l’ha riportato ad antico splendore.
Dal colle di Muggia Vecchia si gode un magnifico panorama sul Golfo di Trieste e fin alla laguna veneta nelle giornate terse di bel tempo. La locale pietra arenaria, menzionata già negli statuti cittadini del 1333 e del 1420, viene ancor oggi estratta in particolare per selciature e piccoli interventi di abbellimento.
Da non perdere il carnevale di Muggia o Carnevàl de Muia, con origini, che si perdono nella notte dei tempi, un grande spettacolo, che dal 1954 propone ogni anno carri allegorici ravvivati da un gran seguito di maschere dai coloratissimi e sgargianti vestiti.
I cibi tradizionali sono le minestre o i brodèti di pesce con polenta o le fritture di pesce. Come dolci le fritòle per Natale, i cròstoli per carnevale, le pìnse e le tìtole per Pasqua con la xùza di tradizione slovena, la classica gelatina fatta in casa, caratteristica nelle borgate periferiche.