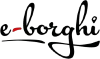Il borgo di Rotondella ha origini molto antiche. Rotondella viene citato nel 1261 col nome di Rotunda Marinis, termine derivato, probabilmente, dalla sua particolare forma circolare e dalla posizione di fronte al mar Jonio. Nel centro storico merita una visita la chiesa madre dedicata a Santa Maria delle Grazie e la chiesa di Sant'Antonio da Padova, appartenente al convento francescano degli Zoccolanti.
Passeggiando per le vie del borgo si possono notare le "lamie” di Bitonte, risalenti al 1600, ovvero archi in pietra a volta, sottostante il calpestio del palazzo di proprietà della famiglia Bitonte, da cui il nome.
Nel 1772 fu costruito il Palazzo Tucci, l’attuale Palazzo Cospito.
Il Palazzo Lelpo, costruito agli inizi del 900, sorge dove prima vi era la farmacia di Benedetta Laguardia, figlia dello speziale Giambattista e moglie di Francesco Antonio Albisinni.
Il Palazzo Rondinelli fu costruito alla fine del XVI sec. dalla famiglia Agnesi, ed è tuttora agibile. Nelle prossimità vi era una torre di difesa (la cosiddetta Torre del Carcere) dotata di un ponte di legno che collegava le due strutture al fine di evitare gli attacchi dei Turchi.
Il Palazzo Albisinni, edificato nel 1770, è in stile barocco con portali e finestre in pietra lavorata da scalpellini giunti da Rivello e da Padula. Il palazzo si compone di molte stanze disposte su due piani, in una di esse si trova la cappella di San Gaetano destinata alle cerimonie religiose. Termina con un ampio terrazzo da cui si può ammirare tutta la costa Jonica.
La storia
Le testimonianze preistoriche di frequentazione umana vicino le valli del Fiume Sinni iniziano a datare già dal Paleolitico Superiore (VIII-VII millennio a.C.). Alla fine del II millennio a.C. dobbiamo riconoscere come preminente al centro della regione la città di Pandosia (l'odierna S. Maria d'Anglona), capitale dei Chaoni, fulcro dei traffici correnti fra l'Apulia e il Bruzio e punto di riferimento dei commerci marittimi del mondo miceneo. Circa un cinquantennio dopo la grande colonizzazione greca achea di Sibari e Metaponto, da elementi ionici ed eolici d'Asia presso la foce dell'omonimo fiume viene fondato il nuovo insediamento di Siri. L'opulenza e il lusso dei Siriti divennero presto celebri ed il suo porto fluviale garantiva un sicuro accesso alle navi lungo queste coste prive di ancoraggi, al centro di un'immensa e fertilissima pianura. Questo stesso sviluppo fu la causa della fine della città, a causa dell'inevitabile urto con le vicine Metaponto e Sibari per la concorrenza commerciale. La coalizione delle vicine città achee determinò la distruzione di Siri tra il 535 e il 530 a.C. Nel contesto delle mutate condizioni storiche, verso il 433 a.C., ad opera di Taranto e Thourioi avvenne la fondazione di Eraclea, poco più all'interno della vecchia Siri, che ne veniva a costituire lo scalo marittimo.
Nel 317 a.C., dopo una lunga offensiva, i Romani presero possesso della regione. A partire dalla tarda età imperiale, soprattutto a causa delle invasioni barbariche la regione cadde nel più completo abbandono, accompagnato dall'impaludamento dei fiumi, dall'estendersi degli acquitrini e dei pascoli e dalla spaventosa avanzata della malaria. La dominazione longobarda portò ad un riassetto militare della zona ed alla conseguente fortificazione dei diversi siti strategici (VI sec. d.C.). L'iniziale penetrazione bizantina non condusse ad un sostanziale mutamento delle condizioni di vita, nonostante la più consistente presenza religiosa di carattere cristiano-orientale. La progressiva netta affermazione della presenza dei Bizantini nei paesi dell'antica Lucania portò alla formazione di numerose chiese vescovili e coincise con una discreta ripresa economica e con l'espansione di comunità monastiche di rito greco e Benedettine. Intanto, col decadere di Eraclea, l'antica Pandosia probabilmente era ridiventata il centro più eminente della zona e, con alterne vicende ed il nuovo nome di Anglona, continuò a dominare l'intero territorio anche in epoca normanna (XI-XII sec.). Quasi certamente a motivo della sua posizione privilegiata che domina la vallata del Sinni dall'alto delle propaggini del Timpone del Caprio (576 m) e permette di spaziare con lo sguardo fino al mare, e forse anche a causa della forma circolare del primo insediamento, Rotondella era denominata in antico con il toponimo di Rotunda Maris. Ancora oggi il paese si presenta visivamente come una vera rotonda, poiché l'assetto urbanistico del centro abitato segue l'andamento rotondeggiante del colle secondo le curve di livello, disegnando la viabilità in forma di una spirale che partendo dalla cima si snoda lungo le pendici.
Nel 1231, Federico II riconobbe alla Chiesa Cattedrale di Anglona il possesso del Monastero di S. Maria del Lauro "sita in tenimento Rotundae Maris". Nel 1369, Anglona venne distrutta da un incendio appiccato da soldatesche e Venceslao Sanseverino, Conte di Tricarico e Chiaromonte, riconfermò al Monastero del Sagittario gli antichi beni e privilegi in Rotunda Maris e Trisaia. Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento il numero degli abitanti di Rotondella finalmente diventò soddisfacente. Per questo motivo, nel 1580 venne innalzata la nuova Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Grazie (allora di dimensioni ridotte rispetto alla forma attuale), che fu aperta al culto nel 1587. Verso la fine del secolo, i Turchi invasero nuovamente la regione, compresa Rotondella, e portarono via circa duecento prigionieri dei quali non si ebbero più notizie.
L'Università (o "Comune") di Rotondella nacque nel 1604 e giuridicamente diventò proprietaria dell'area dell'antica Difesa, benché i Baroni Agnese potessero continuare ad esigere dei crediti su tale loro vecchio possedimento. Già dalla prima metà del Seicento, per volontà dei Doria, nuove attività erano state intraprese da coloro che abitavano il Casale di S. Laura, ai quali andava il merito di aver dissodato i terreni limitrofi e di aver messo a colture le terre. Dal 1680 la popolazione cominciò a crescere in numero considerevole. Gli eventi del primo decennio dell'Ottocento, che tanto segnarono il destino del Regno di Napoli, naturalmente fecero sentire ulteriori ripercussioni pure sul centro abitato di Rotondella che soffrì anche a causa della sua posizione geografica, in quanto il bosco di Policoro offriva un buon rifugio ai briganti, sia isolati che in gruppo. La notte del 30 agosto 1807 è tristemente ricordata per essere stata testimone di saccheggi, stupri e violenze di ogni genere da parte della banda di don Nicola Pagnotta che fece irruzione nel paese.
La legge eversiva della feudalità emanata il 2 agosto 1806 dichiarò abolita la feudalità, per cui tutte le giurisdizioni baronali passarono allo Stato e vennero abolite le prestazioni personali che i possessori dei feudi percepivano a qualsiasi titolo dalle popolazioni e dai singoli cittadini. Dopo il 1811, il brigantaggio fu debellato ad opera della spietata azione del Generale Carlo Antonio Manhés, i cui provvedimenti incisero non poco sulla vita economica di Rotondella, che per circa un anno fu inabitabile e quasi deserta. Il 13 luglio 1820, in seguito al moto popolare, Ferdinando I concesse la Costituzione e Rotondella divenne luogo di un'accesa lotta politica, che culminò nell'assedio a Palazzo Albisinni il 26 settembre dello stesso anno. Oltre alla setta dei Calderari, negli anni 1816-17 anche la Carboneria trovò numerosi adepti in Rotondella e saranno i figli di questi personaggi a rappresentare una novità: nati nel decennio francese e nella prima restaurazione, cresceranno con una mentalità nuova, una maggiore preparazione culturale e un'accresciuta attenzione ai problemi politici. Infatti, saranno gli eroi delle vicende del 1848 proprio coloro che avevano frequentato gli studi universitari a Napoli. Quando, il 29 gennaio 1848, Ferdinando II annunziò la nuova Costituzione ci fu grande fermento tra i liberali, che trovarono una guida e un incitamento in Girolamo Fauchier, Giudice Regio a Rotondella in quell'anno. Si assistette, così, alla crescita di una nuova consapevolezza politica, non più legata ad interessi particolari ma maggiormente tesa al collettivo. Nel paese risultarono essere in numero considerevole gli iscritti alla Giovane Italia e ad altri movimenti e sette di varia ispirazione.