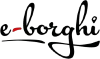La grotta del Cavallone (altrimenti conosciuta come grotta della Figlia di Jorio) venne esplorata per la prima volta nel 1704 da Jacinto de Simonibus, Donat’Antonio Francischelli e Felice Stocchetti, benché la prima traccia di una esplorazione sia la data 1666 incisa, insieme ad altre più recenti, su un masso sito nell’antro d’ingresso. Nel 1904 Francesco Paolo Michetti, per il secondo atto della tragedia pastorale La figlia di Iorio di Gabriele d’Annunzio, realizzò la scenografia ispirandosi all’antro d’ingresso della grotta del Cavallone. Sull’onda del successo dell’opera dannunziana la grotta venne anche chiamata della Figlia di Jorio e richiamò l’attenzione di numerosi visitatori, molti dei quali la descrissero in termini fantasiosi. La grotta fu utilizzata, dopo la distruzione sistematica del paese nel corso della seconda guerra mondiale, nell’inverno 1943-44 quale rifugio per molti abitanti di Taranta Peligna.
Una funivia permette oggi di raggiungere l’ingresso della grotta dalla strada del fondovalle che si dirama a circa sei chilometri nella Val di Taranta Peligna. La funivia parte in località “pian di valle” a circa 750 metri s.l.m. ed arriva a quota di circa 1300 metri s.l.m., sempre nella valle di Taranta. Il percorso interno alla grotta si snoda per un chilometro, con la possibilità di attraversare sale di grande interesse, in particolare per ciò che concerne i primi 600 metri; è qui infatti che si notano innumerevoli stalattiti e stalagmiti. Vale la pena di ricordare la “foresta incantata”, la “sala degli Elefanti” e lo stupendo “pantheon” con la sua “sala delle Statue”. Alcuni punti salienti della grotta sono stati denominati con termini dannunziani come ad esempio la sala di Aligi, l’eremo di Cosma o l’Angelo muto. Del sistema speleologico della grotta del Cavallone fanno parte anche la grotta del Bue, la grotta dell’Asino e la grotta del Mulo.
La grotta è famosa nella letteratura teatrale per essere stata l’ambientazione, assieme al paese di Lama dei Peligni, della tragedia pastorale La figlia di Iorio, scritta da Gabriele d’Annunzio. La grotta nel testo ha valori simbolici e magici, perché vi si nascondono gli amanti Aligi e Mila. Il primo è un giovane di buona famiglia, che deve sposare una donna a lui promessa, ma che s’innamora di Mila; quest’ultima infatti è una povera popolana sopra cui cade il pregiudizio dei contadini locali, definita una strega malefica. Infatti è rincorsa da dei fattori per essere linciata, ma Aligi la protegge, e la protegge dentro le grotte.