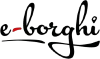L’antica colonia greca di Akrai, secondo l’indicazione di Tucidide, fu fondata dai coloni corinzi intorno al 664/663 a.C., settant’anni dopo la fondazione di Siracusa. Il territorio acrense, tuttavia, risulta essere stato già abitato in epoca preistorica. Secondo Luigi Bernabò Brea è probabile che Akrai nell’827 d.C. sia stata distrutta dalla furia dell’esercito arabo di Aserd Ibn Al Forat, condividendo così il destino di altre 98 città siciliane. Ma in seguito a tale evento, la popolazione, dopo essersi per numerosi decenni dispersa nelle campagne, torna a inurbarsi; prima nella parte bassa dell’acremonte e, successivamente, si ha un processo di insediamento in una zona intermedia, in parte corrispondente con l’odierno centro storico.
Il Teatro Greco
E’ il monumento più insigne dell’area archeologica di Akrai. Definito da Ettore Romagnoli il teatro del cielo, a rendere il particolare effetto di sospensione tra cielo e terra che regala al visitatore. Da esso è, infatti, possibile godere di una straordinaria vista sia della Valle dell’Anapo che dell’imponente Etna. Incerta è l’epoca di realizzazione del teatro; appare comunque plausibile una datazione risalente all’età di Ierone II, quindi intorno alla seconda metà del III sec. a.C.
Il Koilon (cavea), messo in luce da Gabriele Judica intorno al 1824, risulta composto da otto scalette, nove cunei e dodici file di sedili, per complessivi 700 posti circa; le modeste dimensioni spiegano l’assenza di diazoma. Diversamente dagli altri teatri del mondo classico, il teatro di Akrai non ha uno sviluppo angolare superiore al semicerchio e non fu scavato nella roccia. Altro particolare che rende unico il teatro di Akrai è riscontrabile nell’orchestra che non è perfettamente circolare, ma semicircolare. Singolare e mai compiutamente spiegata è l’esistenza e la funzione, sulla parte occidentale della gratinata, di uno stretto cunicolo che pone in collegamento il teatro con il bouleiterion retrostante. Il teatro è privo di paradoi (ingresso del coro) e, in loro vece, esistono due ingressi frontali al koilon, posti ai lati della scena. Il fronte del proskenion (palcoscenico) è allineato alle due ali terminali del koilon così che la scena risulta straordinariamente avanzata rispetto ai consueti canoni. In epoca romana questo, come gran parte dei teatri greci, subì numerosi rimaneggiamenti. Sulla scena sono, infatti, ben visibili i resti di un mulino di età bizantina.
Tempio di Afrodite
Fu scoperto grazie al ritrovamento, ad opera di Gabriele Judica, di un’antica iscrizione, nota come Kaibel 217. Lo studio di questa iscrizione ha consentito agli studiosi di affermare che nell’antica Akrai esistessero tre templi: l’Aphrodision, dedicato ad Afrodite, l’Artemision, dedicato ad Artemide, e il Koreion, dedicato a Kore. Il più importante di questi edifici religiosi, edificato intorno al VI sec. a.C., era certamente l’Aphrodision. Secondo la ricostruzione proposta da Luigi Bernabò Brea, il monumento, ubicato sopra il teatro, era composto da colonne di tipo dorico, sei nella parte frontale e tredici sui lati, per un’estensione totale di m 18,30 per m 39,50. Si trattava, quindi, di un tempio di medie dimensioni che non raggiungeva l’ampiezza dei maggiori templi siracusani. Oggi di questo tempio resta poca cosa e solo i blocchi squadrati del basamento rievocano la presenza di questo luogo di culto.
Compreso tra il tempio di Afrodite e il teatro, la campagna di scavi degli anni 2005/06 ha riportato alla luce le vestigia di un articolato complesso sacro (Tesmophorion) ascrivibile al III sec. a.C., riguardante i riti sacri del culto di Demetra e Kore (Tesmophoiae), costituito da circa 25 ambienti.
Il Bouleuterion
Rinvenuto grazie all’appassionata opera di Gabriele Judica intorno al 1820, fu studiato sistematicamente da Luigi Bernabò Brea solo a partire dal 1944. Dapprima fu confuso, anche dallo stesso Paolo Orsi, con un Odeon; ma lo studioso tedesco Heinrich Bulle svelò la reale natura dell’edificio: il luogo di riunione del senato cittadino, composto da un koilon, una piccola orchestra – perfettamente semicircolare – esposta ad occidente. Era certamente compreso in un vano quadrangolare coperto e conteneva sei ordini di sedili divisi in tre cunei da due scalette, con una capienza complessiva non superiore ai cento posti. Nei suoi pressi doveva trovarsi l’agorà; osserva, infatti il Brea come “l’agorà di Akrai non fosse al centro dell’abitato ma sul lato orientale, nelle immediate adiacenze della porta per cui convergevano in città le vie di Siracusa e Neation”. Al di là del muro di cinta che delimita il bouleuterion si trova una singolare costruzione circolare ritenuta dai più un impianto termale di epoca romana, riattato a battistero in epoca bizantina.
Asse viario
Estremo interesse per le singolarità riscontrabili, suscita tra gli studiosi il sistema viario urbano, il cui asse principale (platea o decumano), in collegamento con le due porte urbiche fendeva da est ad ovest l’abitato. La strada principale era dotata, com’è possibile vedere ancora oggi, di una pavimentazione lavica, posta in luce negli anni ottanta del secolo scorso per circa 300 m. Ha una larghezza media di circa 4 m e, a spazi intermittenti di circa 25 m, viene incrociata da stradine laterali di circa 3 m di larghezza e non pavimentate. Queste stradine, diversamente dai canoni consueti, incontrano la strada principale non ortogonalmente, ma in modo leggermente obliquo. L’espediente costruttivo, secondo gli studiosi, fu dettato dalla necessità di mitigare il forte vento che spazzava il pianoro dove insisteva l’abitato.
Latomie
Nell’ambito dell’area archeologica di Akrai si riscontra la presenza di almeno tre latomie. Due di esse si trovano nelle immediate adiacenze del teatro. L’Intagliata è la più grande di queste latomie: ad essa si accedeva attraverso una porta, ancora ben visibile, posta sotto il teatro. All’interno di quest’area sono presenti numerosi ipogei e sepolture di età cristiana. L’Intagliatella è caratterizzata dal succedersi di nicchie votive contenenti pinakes (tavolette/dipinti votivi) e tombe di varie epoche. Tuttavia l’aspetto che caratterizza quest’area e monopolizza l’attenzione è dato dall’esistenza di un bassorilievo descrittivo. Nella sua parte sinistra è rappresentata una scena sacrificale; nella parte destra un banchetto di eroi; al centro, con funzione unificante, un guerriero romano in atto di compiere un sacrificio propiziatorio o di ringraziamento.