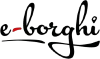Antonino Uccello, creatore della Casa Museo, fu poeta e antropologo. Nacque a Canicattini Bagni (SR) nel 1922. Appena ventenne, maestro di scuola elementare, andò in Brianza; qui, lontano dalla sua Isola, si appassionò al folklore e alle tradizioni popolari. Consapevole dei rapidi cambiamenti sociali, economici e produttivi innescati in Sicilia dal dopoguerra, si attivò, inizialmente durante le sue vacanze, insieme con la moglie Anna Caligiore, in molte campagne di ricerca.
Il suo scopo era acquisire e documentare tutto ciò che era legato alla cultura popolare del suo territorio: usi, tradizioni, oggetti, costumi, musiche, racconti, testimonianze, immagini. Dal 1957, per circa 30 anni, organizzò fra la Sicilia e Milano numerose mostre sulla cultura popolare. Rientrato definitivamente in Sicilia, sentì la necessità di trovare una dimora per il materiale raccolto; acquista, così, un’antica casa a Palazzolo Acreide, creando la Casa Museo, inaugurata il 26 settembre 1971 e che oggi porta il suo nome. Uccello concepì la sua casa come un anti-museo: una casa della civiltà contadina, usufruita come un servizio sociale. E così venne gestita fino al 29 ottobre 1979, data della sua morte. Lontano dalla volontà di creare un museo dei ricordi o delle nostalgie, Uccello concentrò la sua attenzione nell’allestimento di ambienti fortemente contestualizzati, capaci di indicare al visitatore la funzione d’uso di quanto esposto. Non trascurò, tuttavia, di curare la versatilità di alcuni spazi espositivi adibiti a luoghi ove far circolare esposizioni temporanee di differenti testimonianze del mondo popolare, talora richiamando al loro valore estetico ed artistico, talora proponendo letture dei loro più nascosti significati simbolici e comunicativi. La Casa Museo venne acquisita nel 1983 dalla Regione Siciliana e nell’attuale allestimento propone al visitatore, con un rigoroso rispetto della volontà del suo fondatore, l’assetto originario.
Atrio. L’ingresso della casa museo presenta un luogo espositivo teso a creare nel visitatore un’immediata suggestione plastica e cromatica: alle pareti è collegata una collezione di piatti in ceramica (fiancotta), provenienti, in prevalenza, da Caltagirone (Catania). Intorno si trovano sculture in pietra raffiguranti angeli, fiori, colonnine e altre raffigurazioni di portali,mensole di balconi e arredi tombali. In una nicchia a muro sono esposte numerose di uso quotidiano. Un calesse trova spazio accanto ad una ringhiera che delimita l’accesso ad un locale già adibito a stalla.
Cortile. Presenta una scala esterna per l’accesso al piano superiore. In un angolo si trova la cisterna per la raccolta delle acque piovane, che venivano convogliate dai tetti con tegole (ciaramira) a grondaie. Su di essa è uno strumento in ferro (curchera) con una serie di uncini disposti intorno ad un cerchio, utilizzato per poter recuperare il secchio in fondo al pozzo.
Casa ri massaria. Era la cucina e la stanza di lavoro della massaro. Dietro la porta di accesso sono disposte le immagini dei santi protettori, una piccola croce di foglie di palma intrecciata, benedetta nel giorno della Domenica delle Palme, e un ferro di cavallo con un fiocco rosso contro il malocchio. In un angolo trova posto il forno di pietra e mattoni senza canna fumaria (a fumu persu), sicché il fumo si perdeva nella stanza e andava ad affumicare la salsiccia appesa ad un cerchio di legno agganciato al soffitto. Sulla parete del forno c’è una piccola apertura, con un tappo di pietra, per osservare la cottura del pane; al lato del forno un focolare di pietra (tannura) per cucinar. Segue l’angolo con l’occorrent per fare la ricotta: la caldaia (quarara) sospesa ad un travetto di legno sostenuto da due treppiedi; una media (mastredda) adoperata per lo scolo anche dei formaggi e molti piccoli contenitori di canna (cavagni), dove la ricotta veniva deposta. Nello spessore di un’antica finestra murata è ricavato uno spazio con mensole che sostengono numerosi recipienti di terracotta; nell’angolo attiguo si trovano gli attrezzi per la panificazione. Pendenti dal soffitto, appesi a lunghe assi, sono allineati collari da bovini. In un altro angolo della stanza trova posto il telaio con cui la massaia tesseva il suo corredo, le coperte di lana e di cotone (frazzate), le bisacce, il modesto filunnenti (filo da niente) per stoviglie estrofinacci e quanto altro occorreva al bisogno familiare.
Casa ri stari. Era il locare (per stare) dove abitavano gli sposi massari. Vi si trova un letto a due piazze sul quale è sospesa, legata a due boccole fissate in alto nelle pareti contigue, la naca a buolu (culla a volo). Al capezzale, attorno al crocifisso, sono appese stampe di santi. nell’angolo si trova un recipiente di canne intrecciate di forma cilindrica (cannizzo) dove si conservava, al riparo dai roditori e dal’umidità, il frumento per l’annata. Alle parti vi sono ceste fatte con culmi di frumento (canniscia) e stacci per la farina (criva i sita); si trovano, inoltre, una nicchia con una statuina di San Sebastiano, con intorno immagini devote; una pala di Pasqua e due mazzi di frumento intrecciati, collegati con funzione propiziatoria. Seguono nella parete vecchie fotografie di famiglia esposte secondo un ordine rigorosamente gerarchico; al di sotto è collocato un tavolo a mezzaluna sul quale sono posti oggetti di uso domestico. In un’area opposta al letto si aprono due vani a muro in cui si conservano recipienti, brocchi e stampi di terracotta per la confezione dalla marmellata. Completano l’ambiente un braciere di rame, sedie, cassapanche per la biancheria, strumenti musicali, un seggiolino per i bambini e suppellettili di uso familiare.
Stalla. È un piccolo ambiente con volta a botte e pavimento di roccia naturale. In un angolo all’ingresso, sulla destra, si trova una mangiatoia; alle pareti sono appese alcuni finimenti per la bardatura degli animali. La stalla contiene tutti gli attrezzi del massaro con cui portava a compimento il ciclo dei lavori agricoli: falci, aratri, un erpice, zappe, vomeri, bastoni, pale, ditali di canna. Appesi a lunghe assi pendenti dal soffitto, sono allineati collari in legno per ovini e bovini, alcuni dei quali presentano motici ornamentali e figurativi incisi e dipinti.
Frantoio. Era il locale (trappitu) adibito alla produzione dell’olio. La macina verticale in pietra (mola suprana o currituri) avanzava, trascinata da un mulo bendato, sulla macina orizzontale (mola suttana), frantumando le olive che il mastru di pala (maestro di pala) ammucchiava su di essa. Con la poltiglia prodotta il mastru ri cuonsu (maestro del torchio) riempiva i fiscoli (coffi), secchi di fibre vegetali, che si disponevano sotto il torchio in legno azionato a mano con una stanga. La pressione prodotta faceva sgorgare olio misto ad acqua che scolava dentro ad un raccoglitore circolare in pietra lavica (lumera), bordato per il deflusso del liquido. Attraverso una breve imboccatura esso veniva convogliato nelle vasche di decantazione scavate nella roccia dove, per il peso specifico minore rispetto a quello dell’acqua, l’olio galleggiava e veniva raccolto manualmente con un piatto di zinco o di terracotta (lumera), con due labbra a beccuccio, per poi essere versato in vari contenitori. Di fronte al torchio vi sono due vasche in muratura dette a morti (la morte) in cui si scaricava l’acqua di rifiuto dalla quale si ricavava un liquido oleoso per alimentare le lucerne e per la produzione del sapone. In un angolo si trova il torchio utilizzato per la lavorazione del miele. Veniva azionato manualmente per la spremitura dei favi appositamente disposti nelle coffe e dai quali era già scolato il miele di prima qualità. La torchiatura rendeva miele di seconda scelta e materiale utile per la produzione della cera che veniva poi venduta alle botteghe dei ceroplasti (cirari) per la realizzazione di candele, figure di pastori, figure sacre.
Piccolo maiazzè. Serviva come deposito (piccolo magazzino) delle giare – attualmente colegate nel frantoio – in cui si conservava l’olio. Ospita un granaio al cui interno, in un primo vano, è esposto in presepe popolare di recente fattura, in creta cotta al sole e in cartapesta: il paesaggio coi caratteristici muri a secco e le tipiche masserie, rappresenta la campagna dei monti Iblei. Nel secondo vano si trovano un presepe con figurine di terracotta provenienti dal catanese e alcune ceroplastiche. Negli altri spazi espositivi vi sono alcune teche con dentro statuine di cera. Alle parti sono appese pitture su vetro di produzione ottocentesca, con soggetti sacri.
Cortile. All’interno del piccolo del piccolo maiazzé si trova un portico con arco a tutto sesto adiacente ad un altro cortile con accesso secondario ala casa e una scala che porta al piano superiore. In questo spazio è collocato un abbeveratoio per gli animali (scifo). Attraverso una finestra che si affaccia sul portico si scorge una seconda cisterna di acqua piovana utilizzata per il frantoio.
Maiazzé. È l’antico magazzino padronale dove venivano conservate le derrate e la raccolta dell’annata : sul fondo vi sono i grandi ripostigli di legno per il grano e per i legumi, ora adibiti a spazi espositivi. Attualmente il locale ospita mostre temporanee di oggetti e collezioni provenienti dai magazzini della Casa Museo. Pitture su vetro, ceroplastiche, ceramiche, attrezzi per il lavoro, costumi tradizionali, gioielli, strumenti musicali, arredi, immagini devote, oggetti sacri, crocifissi, giocattoli, ex voto, sculture in legno, tavolette votive, mezzi di trasporto: vengono esposti alternativamente nel vecchio magazzino.
Ex stalla. Il locale fu adoperato in passato come stalla; l’acciottolato che costituisce l’attuale pavimento, presumibilmente anteriore al terremoto del 1693, è stato scoperto durante un recente restauro. In esso sono esposti una collezione di pupi, in gran parte provenienti dal palermitano, cartelloni per il teatro popolare, particolari di carretto in legno e in ferro battuto e numerosi giocattoli.
Oltre agli uffici, si trova il magazzino espositivo, dove hanno spazio gli oggetti collezionati da Uccello e non collocati stabilmente negli ambienti sottostanti, nonché le nuove acquisizioni effettuate dalla Regione Sicilia dopo il 1983. Sono i locali dove uccello visse, fino al giorno della sua scompara, con la sua famiglia.