Itinerario per gite fuori porta nei giorni di primavera e non solo. Dall’estremo nord di Torino parte uno dei percorsi collinari più spettacolari del Piemonte. Da Sassi, nota alla fine dell’Ottocento per le sue numerose piole, osterie e ristoranti, si sale a Superga attraversando le colline del Po fino a giungere ai margini occidentali del Monferrato. Si raggiungono poi Baldissero, Pavarolo, Montaldo e Marentino, tra tesori architettonici e buona cucina, panorami e castelli.
La partenza dalla borgata di Sassi, la salita al colle di Superga, la discesa a Baldissero Torinese, la salita a Pavarolo, poi Montaldo ed infine Marentino sono un susseguirsi d’inaspettate sorprese.
L’inizio dell’itinerario impone una sosta alla stazione della tranvia a dentiera Sassi-Superga dove visitare il museo storico allestito dalla GTT (Gruppo Torinese Trasporti) nel quale è esposta una fedele riproduzione della prima carrozza tranviaria a cavalli. La tranvia a dentiera è l’unico esempio del suo genere in Italia, valida alternativa alla macchina e ai sentieri per raggiungere il colle, con oltre tre chilometri di percorso tra panorami, natura e pendenze che arrivano fino al 21 per cento, viaggiando su carrozze d’epoca perfettamente restaurate.
Dai 225 metri di piazzale Gustavo Modena saliamo, costeggiando vecchi muraglioni e antiche ville, fino ai 670 del piazzale antistante la chiesa. Capolavoro barocco di Filippo Juvarra, l’architetto messinese di casa Savoia, Superga affonda le sue origini nel 1706, quando Torino era assediata dall’esercito franco-spagnolo di Luigi XIV. Le milizie piemontesi, insieme con gli alleati austriaci, erano in difficoltà ed il duca Vittorio Amedeo II fece un voto proponendosi di costruire, in caso di vittoria, una grande chiesa in onore della Vergine. Dopo 117 giorni d’assedio l’esercito nemico venne sconfitto ed il duca mantenne la promessa. Alto 75 metri e lungo 51, il complesso è arricchito da sei cappelle con statue e monumenti in marmo di Carrara, mentre la cupola è ispirata alle opere romane del Borromini. Da vedere, all’interno, la cappella del Voto, che custodisce la statua in legno della Madonna delle Grazie alla quale si sarebbe rivolto il duca per vincere la famosa battaglia. La Cripta Reale, che ospita le tombe dei re di Sardegna, l’appartamento reale e la cupola sono le tappe imperdibili della visita. Oltre ad essere luogo d’arte e meta religiosa, Superga è anche nota per il tragico schianto dell’aereo della squadra di calcio del Grande Torino, ricordata da una lapide.
Lasciata Superga si scende alla volta di Baldissero, in un tratto d’itinerario che si snoda in parte nel parco naturale della collina di Superga, tra pioppi, castagni, roveri e robinie, affollato di cinghiali, volpi, tassi, scoiattoli e rapaci come la poiana, il nibbio, il gheppio e lo sparviero. La vista corre alla volta dei borghi arroccati sui poggi. È via Roma a portarci nel cuore Baldissero, all’ombra della chiesa barocca settecentesca di Santa Maria della Spina, che custodisce un bel crocefisso ligneo, un organo a 636 canne, una pala che raffigura San Domenico e Santa Chiara e due cappelle ai lati della navata centrale, una dedicata a San Giuliano e l’altra alla Madonna del Rosario. Tra i borghi più popolosi della collina, Baldissero merita una sosta anche solo per apprezzarne l’ottima cucina locale proposta da trattorie, ristoranti e agriturismi, dove non ci si può privare d’un assaggio di fritto misto alla piemontese, di tagliolini con i funghi, o di una fetta d’arrosto da accompagnare con un vino della zona, una Freisa di Chieri. Terra di vigneti e frutteti, Baldissero ha tra i suoi prodotti tipici il Cari, vino dolce dal profumo di rosa e lampone, ottimo se abbinato con frutta e dessert.
Lasciato Baldissero si imbocca la strada che porta ad una serie di curve che scendono al fondovalle, all’ombra del poggio sul quale Pavarolo è aggrappato. Vi soggiornò per anni uno dei più importanti artisti italiani del Novecento, quel Felice Casorati, vissuto tra il 1883 ed il 1963, che Pavarolo celebra nelle sue strade, che ricorda con eventi e luoghi che qui l’hanno visto lavorare ed ispirarsi, realizzando pregevoli opere pittoriche. Vicoli, affacci sulle valli e tanto verde si uniscono alle viste sul castello, massiccia costruzione circondata da un bel parco. Tra i manieri meglio conservati della collina con belle finestre gotiche, pare fosse collegato al vicino castello di Montaldo tramite una lunga galleria. Al castello si unisce la chiesa settecentesca di Santa Maria dell’Olmo dall’interno ricco di preziosi affreschi e dall’altare maggiore in marmo intarsiato. Bello anche il campanile che domina le valli.
Lasciato Pavarolo si scende per poi salire al colle di Montaldo. Terra di uve e cereali, quest’ultimo è arroccato su un colle boscoso. Svariati vicoli salgono alla volta del castello, un tempo residenza del conte Carlo Emanuele Ferrero d’Ormea, passato poi al conte Ponte di Lombriasco, al Collegio dei Nobili di Torino, ai padri Gesuiti ed ai padri Barnabiti. Altro tesoro del borgo è la settecentesca chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Colonna, suo cuore religioso.
Una suggestiva strada di campagna ci porta a Marentino che colpisce per i variopinti murales delle facciate del centro storico, raffiguranti paesaggi della zona, colline e scene di vita quotidiana, opere di alcuni tra i migliori pittori muralisti italiani. Due sono le tappe imperdibili del borgo: Casa Zuccalà, classico esempio di “vigna” collinare, residenza estiva delle famiglie altoborghesi tra il Seicento e l’Ottocento, che oggi ospita un’importante raccolta d’arredi, e la chiesa parrocchiale dell’Assunta, situata nel punto più alto del paese, dal cui sagrato lo sguardo corre fino al vicino, straordinario Monferrato.

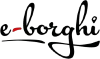





0 Commenti